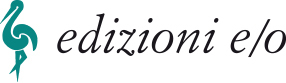Ecco: «Mi chamo Dorotea Giglio. Sono sempre stata pallida: da piccola, da grande, da defunta. Ho i capelli castani e gli occhi pure, così puoi ricordarmi meglio». E’ il 23 luglio 2011 d’una Catania che soffoca nell’afa, quando appunto questa venticinquenne vicina alla laurea in scienze biologiche, che lavora in una cartoleria, si suicida in bagno tagliandosi le vene. Non è un epilogo: ma il vero inizio d’una storia straordinaria cui Viola Di Grado sottopone il suo personaggio sin dalle prime righe: «Due ore dopo la mia morte, mentre ero ancora nella vasca, le sue cavità si sono strette su se stesse, e le sue pareti si sono ispessite come per proteggersi da quest’ultima delusione. Poi è toccato alle palpebre e a tutti i muscoli del mio viso smunto. Poi a quelli di testa e collo, del tronco, della pancia, delle gambe un po’ storte, dei piedi. Dodici ore dopo ero interamente rigida. Poi è toccato al resto del pianeta». Bisognerà subito dire che Viola Di Grado, venticinque anni come Dorotea, ma con studi in lingue e filosofie dell’Asia orientale a Torino e Londra, è stata il caso letterario del 2011 con Settanta acrilico trenta lana, con cui ha vinto il Campiello Opera Prima, rivelando un furioso talento stilistico: così prepotente e esclusivo da prevaricare magari -come qualcuno potrebbe obiettarle (e forse l’ha già fatto)- qualsiasi altro obbligo romanzesco, compreso quello alla narrazione.
Ma sarebbe obiezione ingiusta: perché Di Grado mette il suo talento -e quella sua facilità di metafora che di rado stecca- al servizio d’uno scopo che è eminentemente narrativo, seppure ambiziosissimo considerata la sua età: di provare, cioè, a raccontare l’irraccontabile. Questo, infatti, è il punto: dal momento esatto del decesso comincia, per il corpo di Dorotea, un processo dissolutivo che ha a che fare con un lucreziano e perpetuo moto di atomi. Che, però, esenta l’anima, nella sua pura immaterialità: «Adesso, nel castello di carne in rovina che un tempo chiamavo “io”, sono una completa straniera». Lasciandola come impigliata nei luoghi in cui ha vissuto (la casa materna, il posto di lavoro), a spiare chi è rimasto, per rigiudicare la propria vita (la famiglia, l’amicizia, l’amore) dentro una rinnovata limpidezza, secondo un processo in cui, sciolti tutti i vincoli psicologici e sociali, l’identità diviene finalmente leggera e fluida: «Quelli che vanno al cimitero a trovare i propri cari riderebbero del proprio dolore», solo avessero idea di quanto più grande sia quello di chi non c’è più.
Dorotea arriva al suicidio dopo una vita segnata dagli abbandoni: quello di zia Lidia, anch’essa suicida, 16 anni prima che lei nascesse; quello del padre («ma a quel tempo ero cieca e incompleta e attaccata alla placenta di mia madre»); quello di Lorenzo che la lascia con un sms. Dovrei dire dei personaggi che affollano il libro (la madre depressa, la bella zia Clara e le sue vicissitudini) e di come Dorotea contempli ora il mondo che ora va avanti senza di lei. Ma concludo così: il secolo scorso era iniziato coi morti di Pascoli, che chiedevano queruli di essere ascoltati, e si è chiuso con quelli di Satta che, nel Giorno del giudizio, imploravano d’essere liberati del peso di essere vissuti. Viola Di Grado accetta quelle conclusioni: e ci chiede d’aver fede nell’invisibile, per provare, da lì, a raccontare la vita. Che è poi il suo modo di scommettere ancora sul romanzo. Oltre il romanzo.