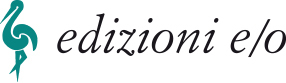«Dalle stragi alla tv forzista, nessuno crede più alle notizie ufficiali». Massimo Carlotto scrive l’autobiografia di un paese criminale
Per scrivere La terra della mia anima, Massimo Carlotto ha voluto scavare un tunnel laterale nel filone noir dei suoi romanzi. È la storia di Beniamino Rossini, uno dei “suoi” protagonisti, nella vita uno dei suoi migliori amici. Qualche anno fa Beniamino, condannato in via definitiva da un cancro, gli ha affidato le sue memorie di delinquente. Carlotto ne ha ricavato una potente narrazione in prima persona, un’autobiografia dell’Italia criminale degli anni 60 e 70. Siamo ad anni luce dai romanzi precedenti, quelli cinici e balordi, popolati di assassini che covano gelide vendette, sadomaso impotenti, volontari alcolizzati e galeotti finto-redenti. La terra della mia anima semmai potrebbe essere un prologo: è l’epopea di una canaglia perdente, cresciuta in montagna a fare il contrabbandiere, tra memorie di resistenti e comunisti che gli hanno insegnato troppa umanità per stare al passo con i tempi e trasformarsi in boss delle nuove spregiudicate mafie. «Il mio libro più difficile, finora», spiega Carlotto, con l’eterna inflessione nordestina e una voce che sembra il sax soffiato di un altro suo amico, il musicista Maurizio Camardi. Nel libro c’è il suo sax, c’è la musica di Ricky Gianco. Un ritratto di famiglia, gli amici di Beniamino. «All’inizio ero perplesso. Questo libro mi costringeva a percorrere territori della memoria in cui non avevo voglia di tornare. Ma le storie erano straordinarie. Alla fine mi ha permesso di capire interi pezzi di storia italiana. I fatti sono quelli che mi ha raccontato. I nomi sono un po’ cambiati, ci sono persone ancora, diciamo così, attive nel ramo».
È un’autobiografia della criminalità italiana, fino a quando deve cedere il passo alle nuove mafie perché non accetta le sue regole, ovvero la mancanza di regole. È così? Sì, non le accetta e per questo viene espulsa dal ciclo produttivo criminale. La globalizzazione dell’economia ha imposto una rivoluzione epocale anche nel mondo della criminalità. Le nuove organizzazioni si comportano da multinazionali del crimine. Il punto di vista di Beniamino è interessante. Diceva spesso che queste nuove organizzazioni, soprattutto quelle straniere, assomigliano sempre di più alle multinazionali del tabacco con cui aveva a che fare negli anni 60, quando faceva contrabbando di sigarette.
Voleva scrivere un romanzo storico? Mi interessa ripercorrere certi periodi per poter raccontare le mie storie. Storie molto belle, importanti. Il fatto di usarle per raccontare grandi periodi storici può essere utile. La prima volta mi è successo con le Irregolari (sulle madres argentine, ndr). Fra un anno uscirà un vero romanzo storico, una storia di Resistenza di italiani in Francia. Una storia scura, noir. Mi interessa il tema della memoria, non sono entusiasta della corsa al confronto con la destra.
Allude al confronto fra Fini e Bertinotti? Lei non avrebbe accettato? No. Credo in una netta distinzione culturale. Il che non significa spaccarsi la testa reciprocamente, ma mantenere radici e memoria, senza confonderla con quella dei ragazzi di Salò. E non parlo da veterocomunista. È per un fatto di chiarezza dentro la sinistra. Si rischia di liquidare il passato senza averlo messo bene a fuoco. Si è santificata la Resistenza, facendo finta che non sia esistita un’altra storia, un po’ diversa. Prima di arrivare al confronto, manca ancora molta strada.
La terra della mia anima è anche un romanzo sul carcere. Ancora una volta lei denuncia che la detenzione non riabilita, condanna il reo a non uscire più dal giro. Avevo deciso di non farlo più. Ma Beniamino ha insistito molto. Diceva che questo paese non ha memoria. Che bisognava raccontare come il carcere si è trasformato negli anni, dall’epoca delle rivolte alla grande speranza della riforma Gozzini, al crollo della speranza. Per me è stato complicato scriverne, ma alla fine mi sono reso conto che aveva ragione lui, era una storia che andava raccontata.
Cosa pensa dell’indulto? Un atto insufficiente ma giusto. E del resto era una scelta obbligata, la situazione in carcere era ormai indecente. Di solito i politici non hanno voglia di mostrarsi clementi, per paura di perdere l’elettorato. Ma in questo caso la situazione, dopo gli anni del ministro Castelli, era veramente degenerata.
Nessun dubbio? Neanche quando legge di chi,“indultato”, torna subito a delinquere? Chi esce dal carcere è disperato. Qui da me, in Sardegna, alcuni lo dicevano apertamente: usciti fuori, non sappiamo dove andare. Uomini che non hanno famiglia, né un tessuto sociale che possa accoglierli. È fisiologico che tornino a delinquere, che siano usciti con l’indulto o per il fine pena. Il vero problema ’incapacitˆ della politica di affrontare il disagio sociale, che non sia attraverso una risposta giudiziaria, poliziesca, carceraria. Gli effetti si vedono. Abbiamo avuto la migliore riforma penitenziaria d’Europa, la legge Gozzini, poi affossata perché non dava immediatamente risultati. Ma la strada è quella, se vogliamo rispettare la Costituzione, in base alla quale i cittadini che finiscono dentro devono essere recuperati.
La sua scrittura a volte ha il passo del giornalismo d’inchiesta, in Nordest persino in maniera esibita. L’ha stupita la nuova primavera di un genere dato per morto? Effettivamente negli anni scorsi ero sfiduciato, e credevo che il noir dovesse raccontare storie anche a causa del grande vuoto del giornalismo d’inchiesta. Ne è nata una scrittura contaminata, interessante. Anche adesso sto scrivendo un romanzo a quattro mani con un giornalista, sul tema della sofisticazione alimentare. Ma ora qualcosa è cambiato. È cambiato il clima politico, la percezione della gente. Dipende anche da quello che è successo intorno all’11 settembre. La controinformazione e le inchieste parallele hanno determinato una sensibilità diversa da parte dei cittadini. Poi qui in Italia quello della verità è un tema profondo. Forse siamo stanchi di un paese che non ha il senso della verità, da piazza Fontana in poi è stato ammazzato giorno per giorno. Nessuno crede più nelle verità ufficiali. Il berlusconismo è stato il colpo di grazia.
Altro tema del romanzo è la corruzione delle forze dell’ordine. Non crede nella giustizia? Non posso fare a meno di crederci. La giustizia deve regolare le faccende fra cittadini e cittadini, e fra cittadini e lo Stato. Ma siamo circondati da un finto buonismo che ci racconta le forze dell’ordine in modo falso e che per altro non serve nemmeno ad aiutarle a crescere. La corruzione aumenta, a livello europeo è un fenomeno evidente, determinato dalla nuova criminalità. E dobbiamo riconoscere che una parte delle forze dell’ordine non crede nello Stato democratico. Genova 2001, con una rottura fortissima con la società civile, ne è stata la prova. Lì è stato chiaro il cambiamento nel modo di gestire la piazza. Oggi il manifestante è considerato un delinquente in fragranza di reato.
Lei ne ha scritto in uno dei suoi noir. Il noir non è ancora passato di moda? No, perché è la letteratura della realtà. Però è in crisi perché gli editori pubblicano di tutto e abbassano la qualità del noir. Né esiste più quel circuito di scambi continui fra autori. Quel porsi la domanda fondamentale: cos’è importante raccontare di questo paese? Gli editori pubblicano cose che non c’entrano nulla con la realtà, roba da leggere in metro, storielle che non ti fanno entrare nelle contraddizioni della nostra società. A lungo andare questo stancherà i lettori.
C’è lo zampino del cinema e della tv? Del cinema no, perché i produttori non ci credono e non lo fanno. La tv propone un prodotto da prima serata, con regole fisse. Ogni tanto qualche autore riesce a infilare un tema un po’ meno finto, un poliziotto omossessuale, una polizia un po’ dissacrante. Ma la tendenza generale è la divisa da mulino bianco, il bene trionfa sempre sul male. E la gente lo guarda perché ci sono attori belli, ma non ci crede più, sa che è tutto finto.
Però a volte gli autori noir sembra che scrivano sceneggiature più che romanzi. Il suo ultimo libro guarda un po’ al teatro. È così? Io lavoro sulla velocità di lettura. Mi piace scrivere romanzi in cui il lettore entra e dimentica il latte sul fuoco, non sente il cellulare. È una scrittura adatta anche al cinema e al teatro.
Un’altra delle sue contaminazioni è con la musica. Ce n’è sempre tanta nelle sue pagine. Ne imita il ritmo, la nomina, spesso utilizza canzoni. Con Beniamino è stato uno strano percorso del destino. Io lavoro da anni con Ricky Gianco, e Ricky era il suo cantante preferito, dai tempi in cui si chiamava Sann. Così, quando registravo le sue storie, c’era la musica di Ricky, dentro e fuori il racconto. La musica per me è sempre più importante. Per il romanzo sulla Resistenza sto lavorando a un progetto con YoYo- Mundi. E fra due anni uscirà la storia di due musicisti, uno italiano e uno armeno. Non poteva che andare così, a forza di lavorare nella contaminazione fra musica e letteratura.