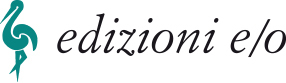Non segue il dibattito italiano, e non sa niente di Tq. Non le interessa il ruolo dell’intellettuale in Italia, dove è nata e cresciuta, e neppure in Gran Bretagna, dove adesso vive. Della politica, poi, non le importa niente.
Viola di Grado, lunghissimi capelli biondi e occhi scuri, rossetto nero sulle labbra e ombretto azzurro, sembra un alieno sbarcato per caso in quel marasma incontrollabile che è il mercato editoriale italiano. Eppure lei, che ha ventitré anni e ha pubblicato quasi otto mesi fa il suo romanzo d’esordio “Settanta acrilico, trenta lana” (e/o, pp. 189), nel sangue ha Sciascia e De Roberto di cui il padre, Antonio Di Grado, è uno dei massimi studiosi. Ma di Sciascia e De Roberto, Viola non vuole parlare, perché preferisce Mrs Dalloway, “il mio libro preferito in assoluto, un buon esempio di storia a servizio della lingua”.
Nelle sue parole però, nell’esordio che l’ha portata a essere selezionata fra i dodici finalisti al Premio Strega e a meritare il prestigioso Campiello Opera Prima, diventando la più giovane vincitrice del concorso seguita a ruota da Silvia Avallone e Paolo Giordano, non c’è niente del capolavoro di Virginia Woolf e, anche a sforzarsi, nella giornata di Clarissa Dalloway, e di quel mercoledì di giugno così intenso e pervaso di angoscia che culmina con una morte e con una festa, non si trovano che rare similitudini.
Di Grado, infatti, racconta della giovane Camelia, che vive a Leeds un inverno gelato e infinito. Camelia, una giovane donna arrabbiata con la vita, che si sfoga con tutto ciò che non le può rispondere, che non le può sfuggire: i fiori sono come i vestiti, inutile materia in suo possesso che sulla sedia appaiono come “pelli di animali scuoiati”.
Camelia che prova piacere a distruggerli, a mutilarli, a ricercare quella bruttezza perfetta che è propria degli storpi, dei malati, e che vagamente ricorda quella di Septimus in Mrs Dalloway.
Camelia che ha una vita scandita da una routine sempre uguale, sempre identica. Tutto è fermo a quando il padre è morto in un incidente d’auto con l’amante. Le cose dovrebbero riprendere a scorrere, ma Camelia come sua madre Livia, che suona il flauto (come l’autrice) e ha rinunciato alla vita per fotografare inutili vuoti, per fotografare buchi, è avviluppata nell’abulia più dolce: traduce dall’italiano all’inglese manuali per lavatrici, non smette di tagliare vestiti o recidere fiori. Poi incontra Wen, che di lavoro fa l’insegnante di cinese, e allora tutto cambia per restare uguale perché Camelia passa dall’estremo del silenzio e del rifiuto del cibo, all’ingordigia di parole, contenuti, alimenti. Perché Camelia, forse, scopre l’amore.
Per un libro la cui trama sembra corrispondere al profetico discorso di Tancredi in cui spiegava “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, in un libro in cui tutto è immobile, la lingua arriva a farsi potenza come di rado succede nei romanzi contemporanei. La forza con cui Viola Di Grado racconta si fa venata d’invenzione, di un tentativo di invenzione che ingloba tanto le parole quanto, soprattutto nella porzione finale, la storia stessa, e che lei spiega così: “La sperimentazione nel mio romanzo è maggiormente sulla lingua, ma un altro aspetto che mi sta a cuore è l’anteposizione delle trame simboliche rispetto alla trama effettiva, all’intreccio. Creare una serie di piste simboliche a circuito chiuso e lavorare su di esse in modo che la totalità della trama sia contenuta in ogni singolo simbolo, come in un gioco di specchi…”. E così, in contrapposizione al potenziale magico, Di Grado mira in alto e non si fa problemi a dirlo. “Volevo inventare un realismo surreale, simbolico, che sia crudo e carnale, verosimile ma allo stesso tempo straniato dalla realtà vera, insomma un mondo simbolico a sé stante di cui la realtà effettiva fosse solo un aspetto”.
A sentirla parlare, sembra proprio che sia un’aliena e che davvero non abbia niente in comune con i suoi coetanei con cui, forse, condivide le ambizioni e le pagine di Nazione Indiana, su cui dice di scrivere ogni tanto “commenti di critica e di opinione”. In fondo, chi avrebbe il coraggio di scrivere frasi come “Il sole è un remake a basso budget dei suoi occhi” o “Spade di pioggia mi sfondavano il cervello”? Probabilmente nessuno, ed è questa la forza di questa scrittrice che spiega di essere interessata “alle storie particolari, anche se quando una storia è ben raccontata può raccontare tutto” e ribadisce con forza che “tutto è funzionale alla lingua, perché la lingua è quella che succede ancora prima della storia”.
Di Grado ha le idee altrettanto chiare sulla sua casa editrice (“Ho scelto e/o perché mi sembrava avere un catalogo più serio rispetto a tutti gli altri editori in Italia”) e sul mercato editoriale: “In Inghilterra rispetto all’Italia c’è più varietà. Le scelte italiane spesso si somigliano e a volte in libreria mi sembra di sfogliare dei libri che mi pare di aver già letto. Il problema dell’Italia è che non esiste la sperimentazione”. E ancora: “Il mercato italiano mi sembra fortemente ossessionato dall’idea della vendibilità, e la qualità spesso ne risente, va in secondo piano”. Diventa così difficile trovare dei libri che le piacciano, alla fine cita l’esordiente Veronica Tomassini che con Laurana ha pubblicato “Sangue di Cane” e un’altra scrittrice che conosce molto bene. Si tratta di sua madre, Elvira Seminara, che ha appena pubblicato “Scusate la polvere” con Nottetempo. E il resto? “Ho dei gusti molto difficili” spiega, ed è una fortuna che qualcuno non abbia vergogna ad ammetterlo.
Anche adesso che è impegnata a studiare per finire la laurea specialistica in filosofia cinese e giapponese a Londra, ed è già decisa a restare lì anche per un dottorato, la cosa più importante resta la scrittura perché “tutto, a partire dai i miei studi, per me è funzionale alla scrittura, delle porte che mi si aprono in testa per i romanzi”. E così Di Grado, ora che il suo esordio è in via di traduzione in mezza Europa e arriverà anche negli Stati Uniti con Europa Edition, sta lavorando al suo secondo romanzo e non si vergogna ad ammettere che “ancora non so che cosa ne sarà di me”. Forse lei no, ma e/o difficilmente se la farà sfuggire.
- Home
- Recensioni
- Un primo appuntamento